Manuela Simoni
Erzsébet
Báthory: un autoritratto doppio
[I parte]
Nota: Il presente scritto, diviso in
due parti, è da considerarsi una biografia romanzata che prende
sì spunto da fonti storiche ma in modo letterario e senza alcun
tipo di intento storiografico in senso stretto.
 |
Erzsébet
Báthory in un ritratto senza data, rubato dal museo di
Cachtice nel 1990. |
In
fondo, forse, sono libera come lo sono sempre stata. Nessuno può
privarmi di ciò che sono. Nessuno può cancellare quello
che è stato, nessuno può uccidere la mia mente senza uccidere
il mio corpo. Ed io sono libera di navigare nei ricordi di quello che
ero, di quello che sono tutt'oggi e che sarò sempre.
Che spezzino la mia vita se è quello che desiderano perché,
solo così, potranno impedirmi di provare quell'eccitazione che
ancora mi accarezza e mi scuote quando mi abbandono ai ricordi. Non
ci sarà redenzione per me, mai rinnegherò la mia natura.
Solo in questo d’altronde consisterebbe il vero peccato.
Mi hanno privato del sole e della luce ma finché avrò
aria da respirare avrò una mente per ritornare indietro. Fiera
di aver ascoltato i miei demoni.
Al buio i miei pensieri diventano così luminosi… E tutto
diventa reale.
Ho vissuto talmente intensamente da non provare dolore nell'essere rinchiusa
qui. La sofferenza a cui ero stata costretta in gioventù è
servita nella mia lotta per la ricerca dell'appagamento.
C'è una tale pace… Solo quando la mia immaginazione sarà
esaurita, solo quando un minimo frammento del mio passato mi apparirà
noioso, solo quando le mie dita sfioreranno una pelle diversa da quella
morbida e delicata, allora potrò abbandonarmi alla morte. Ma
solo quando lo deciderò io, com’è sempre stato.
Come possono pensare costoro che la morte mi spaventi, che la prigionia
mi torturi?
Loro, stupide menti tenute schiave, fantasie oppresse, istintività
frustrate dallo stesso Dio che derideva suo figlio costretto su di una
croce, riversano su di me tutta la loro nullità.
In fondo, io e quel Dio siamo fratelli.
Oh se i miei boia sapessero che non hanno il potere di privarmi di nulla.
Ma non lo sapranno mai, troppo ciechi per capire che ci sono cose che
vanno oltre una punizione corporale. Quanta banalità insozza
il mondo.
Se adesso lo desidero, il sole può splendere come in una mattina
d'estate, lo posso sentire sulla mia pelle, quel calore.
Ed ecco che mio fratello è qui con me, sento il suo fiato tiepido
e la sua voce è un sussurro.
Come l'acqua di un torrente che scorre potente e al contempo leggera
io scivolo indietro nel tempo e mi ritrovo bambina, in piedi, nell'atrio
della mia vecchia casa.
Mio
fratello Istvàn mi stava dietro, una mano poggiata sulla spalla
mentre con l'altra mi avvicinava il viso al suo e mi sussurrava nell'orecchio.
Intanto la musica che aveva aperto le danze, in quel dì di festa,
suonava forte intorno a noi, le sue labbra mi solleticavano la pelle mentre
lui si abbandonava nei racconti delle sue notti focose con l’ amante
francese, senza tralasciare il minimo dettaglio dei suoi rapporti proibiti.
Io ascoltavo rapita, cercando di immaginare quel piacere a me sconosciuto,
quei giochi così diversi da quelli che la mia balia soleva farmi
fare.
Allora ogni notte, prima di addormentarmi, coccolavo il mio sonno alimentando
la mia fantasia: tramutavo il mio corpo facendolo divenire quello di una
donna, i seni prominenti e i fianchi larghi e fertili, fino a sentirlo
pronto a prestarsi ai desideri di un uomo addormentandomi così
con il sorriso sulle labbra.
Oh com'ero legata al mio caro fratello. Quando rientrava in casa ero sempre
la prima ad accoglierlo, a ricevere il suo bacio sulla fronte. Lui invece,
appena poteva, mi accompagnava in lunghe cavalcate immersi nella natura
fresca e selvaggia. Come eravamo felici. Soli, irraggiungibili, mentre
galoppavamo fianco a fianco lasciandoci ogni cosa alle spalle senza voltarci
mai.
Allora mi sembrava di non poter desiderare altro.
Lui, sangue del mio sangue, l'unica persona che riusciva a calmare le
mie crisi che mi accompagnavano da quando ho memoria. Le serve si agitavano
sbigottite non sapendo come tranquillizzarmi, i miei genitori mi guardavano
compassionevoli e colmi d'angoscia mentre lui rimaneva impassibile, mi
prendeva la mano e stava con me senza dire nulla. Avvenivano all'improvviso
e molto di frequente. Il medico che assiduamente accorreva a visitarmi
aveva finito per cedere: nessuna malattia sembrava nascondersi nel mio
corpo e l'unica possibile causa del mio male era l'incesto compiuto dai
miei genitori. Quindi nessuna cura pareva esistere per placare quella
rabbia immotivata che sentivo crescere in me e che non sapeva come trovare
sfogo e che mi rendeva violenta e che mi distruggeva da dentro. Mi sentivo
impotente contro il mio dolore non sapendo come placare la mia ira e da
questo ne conseguiva un profondo malessere fisico, spesso accompagnato
da violente convulsioni. Ma se Istvàn era con me, ben presto ritornavo
serena e ritrovavo il sorriso.
In famiglia d’altronde ero amata e viziata. Dalla servitù,
dai miei fratelli e dai miei genitori che mai mi avevano negato qualcosa
vedendo la loro gioia nella mia, motivo per il quale quando me ne dovetti
poi distaccare ne risentii profondamente.
La
prima volta che scoprii la morte ero solo una bambina. Nessuna dolorosa
perdita familiare, nessun lutto accompagnato dalla sofferenza, ma semplice
e brutale morte. Descrivere quello che provai quel giorno non è
semplice.
C'era una festa quella sera nel nostro castello, degli zingari erano stati
invitati per intrattenere la corte. I loro spettacoli mi divertivano moltissimo:
le loro danze, l'allegria e i colori che dipingevano l'ambiente. Ma quando
l'ora si fece tarda mi dovetti ritirare a riposare. Dormivo profondamente
da ore quando un urlo straziante spezzò il mio sonno. Aprii gli
occhi assonnati ma tutto taceva e in un istante mi convinsi di aver sognato.
Ma ecco di nuovo quelle urla, più prolungate adesso, accompagnate
da qualche lamento di dissenso. Subito mi rizzai a sedere ed abbandonai
il mio letto caldo, rabbrividendo del contatto dei miei piedi contro il
pavimento freddo e, con passo leggero, abbandonai la mia stanza scivolando
lungo il corridoio, giù dalle scale.
Aprii lentamente la porta, mantenendomi ben celata dietro il battente
ed origliai apprendendo che uno degli zingari era stato condannato a morte
per aver venduto i suoi figli ai Turchi. La sua sentenza era stata fissata
all'alba.
Ritornai di corsa nella mia stanza con il cuore che mi batteva all'impazzata
in petto sentendomi colma di emozioni. Mi sedetti sul letto a gambe incrociate,
coperta solo della mia camicia da notte. Restai immobile con lo sguardo
fisso alla finestra, infreddolita e assonnata ma ben determinata a portare
a termine ciò che avevo deciso. La curiosità di assistere
a quella condanna vinceva contro ogni fastidio fisico. Quante volte, durante
le conversazioni in famiglia, ne avevo sentito parlare ed avevo provato
ad immaginarne una. Adesso avrei potuto assistervi di persona.
Quando le prime luci dell'alba rischiararono il cielo mi alzai dal letto
con il cuore in gola per l'emozione. Indossai frettolosa un abito scelto
senza troppa cura dall'armadio e mi precipitai fuori dal castello raggiungendo
il luogo dell'esecuzione.
I soldati si stavano preparando. Gli zingari erano raggruppati in disparte
e si tenevano vicini l'uno all'altro: qualcuno singhiozzava, altri si
tappavano gli occhi per non assistere ma la loro tristezza non bastava
a spegnere i colori delle loro vesti e il brillare dei loro gioielli che,
sotto i primi raggi sottili, apparivano ancora più sgargianti.
Oh come sono freschi quei ricordi, proprio come se mai avessi abbandonato
quel luogo, come se i miei occhi ancora stessero assistendo, ancora e
ancora, ad una perenne condanna. Quelle sensazioni, quelle prime emozioni,
le sento di nuovo vive in me che strisciano e che mi si arrampicano per
le caviglie, abbracciano le mie gambe, si insinuano tra le cosce ed entrano
dentro. Nello stomaco si attorcigliano dandomi dolci scariche di eccitazione.
Si affievoliscono e tornano giocando con il mio cuore e mozzandomi il
respiro per poi rendermelo generosamente.
Un gruppo di uomini aveva preso un cavallo e lo teneva fermo per le briglie
immobilizzandolo come meglio poteva. Un po’ goffamente e a fatica
lo costrinse a sdraiarsi su di un fianco. La bestia era inquieta come
se il suo istinto già lo avvisasse della sua fine imminente. Tuttavia
rimase immobile per qualche minuto e solo quando uno dei soldati gli squartò
il ventre con un grande coltello questa oppose un ultimo atto di resistenza
alla ricerca della salvezza. Tese i muscoli del collo ed emise un nitrito
disperato che riecheggiò tutt'intorno fino a spegnersi in un mugolio
soffocato. Scalciò con poca forza e tentò di alzarsi. Per
un attimo diede l'impressione di essere riuscito a vincere la morte rimanendo
ritto in piedi, ondeggiando leggermente come sospinto dal vento, mentre
le sue zampe si inzuppavano della sua vita che scivolava via. Le sue ginocchia
cedettero, gli zoccoli annasparono come se improvvisamente il terreno
sottostante non esistesse più, come se non potessero trovare appiglio.
Cadde a terra con un tonfo attutito e una zingara urlò.
Mentre il sangue dell'animale iniziava ad allargarsi sul terreno lastricato
questo ancora scalciava con gli zoccoli come se sognasse di galoppare
in una prateria, in preda agli ultimi spasmi ma i suoi occhi, grandi e
lucidi, già avevano perso la vivacità della vita.
Ricordo di aver pensato: «Allora è così quando si
muore.. ancora il nostro corpo si muove ma non ci è più
dato di saperlo.» Quindi mi alzai sulle punte dei piedi per meglio
vedere.
Lo zingaro venne preso di forza e a nulla valse il suo tentativo di opporsi.
Puntò i piedi a terra cercando di liberarsi dalla presa ma ben
altro sarebbe servito per fermare i due boia. Allora, vedendo vano ogni
suo sforzo si lasciò andare, come fosse già morto, lasciando
che le sue gambe strisciassero al suolo. Evidentemente però, il
ventre aperto dell'animale pronto ad accoglierlo dovette apparirgli agghiacciante
a tal punto che riacquistò un’improvvisa vitalità
in un’ultima lotta per la sopravvivenza. Nessuna speranza gli fu
concessa: fu sbattuto violentemente a terra, il viso nel sangue dell'animale,
bestia tra le bestie. Fu legato mani e piedi. Tuttavia sembrava proprio
non riuscire ad accettare la sua sorte.
Iniziò a supplicare e gemere come un bambino, chiedendo pietà
pur sapendo che non gli sarebbe stata data. Era uno spettacolo penoso
vedere come un uomo in preda alla disperazione potesse rinunciare a tutto,
al suo orgoglio, alla sua dignità, al suo stesso essere uomo pur
di avere salva la propria vita.
Questa scena patetica non fece che aumentare in me quella rabbia che lo
zingaro mi infondeva. Fremevo nell'attesa della conclusione della sentenza
eppure al contempo avrei voluto non finisse mai.
Con mio sommo piacere lo zingaro venne preso e sistemato nel ventre del
cavallo, accuratamente svuotato delle sue interiora per poi essere ricucito
con precisione, imprigionandolo definitivamente in quella singolare gabbia
da cui era stata lasciata libera solo la testa.
Come mi sentivo strana… eccitata e gli occhi mi pizzicavano. Non
sapevo spiegarmi se fosse per l'emozione di aver assistito a qualcosa
di proibito o per la scena stessa, tuttavia quella particolare euforia
che mi aveva colta perdurò per tutta la giornata, evitandomi le
consuete crisi di rabbia.
L'unica domanda che mi feci a proposito fu semplicemente cosa si doveva
provare ad essere imprigionata nel corpo di un cavallo. La mia risposta
fu che i cavalli erano preferibili animali da cavalcare. E così
feci quel pomeriggio.
—
Quando
fui promessa sposa a Ferenc, a seguito della perdita del mio amato padre
György, avevo undici anni. Lui era di sette anni più grande
e sapevo bene che non era suo desiderio quello di legarsi ad una donna
mentre aveva come unico sogno quello di dedicarsi totalmente alla carriera
militare.
Il solo pensiero che avrei dovuto trasferirmi in una nuova dimora per
dividere la mia vita con un uomo mi spaventava e mi colmava di gioia nel
contempo. Ricordo piacevolmente le sere passate nella mia stanza con il
mio Istvàn, sdraiati l'uno vicino all'atro sul letto morbido, mentre
lo supplicavo di raccontarmi ancora qualcuna delle sue notti proibite,
consapevole che presto, anche io, avrei potuto provare le stesse sensazioni.
Lo tormentavo con i miei dubbi: il mio corpo era quello di una bambina,
magro e per nulla formoso… Cosa avrebbe pensato Ferenc? E se mai
fossi diventata una donna?
Ma lui mi rassicurava paziente, coccolandomi, dicendomi che dovevo solo
saper aspettare e presto anche io sarei diventata fonte di desiderio e
ammirazione. Dopotutto, mi fece notare, lo ero già… Forse
che non mi ero mai accorta che lui stesso mi desiderava da sempre? Che
mi amava sopra ogni cosa? Ed io, sentendomi immediatamente confortata
dalle sue parole, mi abbandonavo serena alle sue carezze…
Purtroppo tutta la mia euforia era destinata a spegnersi presto. Mi fu
imposto di trasferirmi a casa della mia futura suocera Orsolya. Il mio
sogno di essere la padrona del castello, che camminava elegante per i
corridoi, ingioiellata e temuta, conducendo una vita spensierata, al momento
non poteva restare che tale: solo un sogno distante.
Fin dal primo giorno sentii di odiare Orsolya con tutta me stessa così
come odiavo la dimora di Lekà. Sfogavo la mia tristezza scrivendo
lunghe lettere alla mia cara madre, supplicandola di riportarmi a casa
ma la sua unica risposta non poteva essere che quella di pazientare, che
le cose sarebbero cambiate dopo il matrimonio. Allora scappavo a cavallo
trovando in quella corsa un po’ di respiro, sentendomi d nuovo libera
benché consapevole che fosse solo una passeggera illusione. Ripensavo
a quei pomeriggi con Istvàn, godendo della frescura degli alberi
e dell'inebriante profumo della natura, chiudendo gli occhi mentre l'aria
fresca mi carezzava la pelle scompigliandomi i capelli.
Orsolya
era una donna dall'aria austera e dai modi severi, un carattere chiuso
e freddo da non consentire nessun tipo di rapporto amichevole e che non
mi concesse mai alcuna consolazione alla mia disperazione. Le sue regole
erano rigide, inflessibili ed io ero costretta a sottostarvi senza possibilità
di appello, sollevata solo dal pensiero che, mentre il mo corpo si sottometteva
ubbidiente ad ogni sua imposizione, la mia mente rimaneva da lei incontrollata.
I miei cari erano lontani ed io ero sola in un luogo che non conoscevo,
circondata da gente ostile. La mattina mi dovevo svegliare presto per
iniziare le mie lezioni e l'unica mia fortuna era che già, la mia
famiglia, aveva provveduto a darmi un istruzione adeguata, cosa insolita
per le ragazze della mie età e che rendeva meno dure le ore che
vi dovevo dedicare.
Ma ogni mattina, quando mi svegliavo, era come se dovessi andare incontro
all'inferno.
Era mio compito, prima del matrimonio, di imparare il latino, l'ungherese
e il tedesco. Dovevo divenire esperta nel comandare la servitù,
avere un portamento regale da poter sfoggiare in società, occuparmi
delle tasse da riscuotere al popolo. Non mi era permesso di oziare e dovetti
abbandonare per sempre gli abiti maschili che tanto mi piaceva indossare
quando ancora non ero vincolata dalle tante regole e, soprattutto, mi
era impedito di esprimere qualsiasi tipo di idea personale. Per me era
terribile: io che avevo sempre amato i piaceri della conversazione e il
confronto con gli altri adesso potevo solo tacere e chinare il capo.
La notte, malgrado la stanchezza, masticavo il mio rancore per quella
donna, ingoiando tutto l'odio che nutrivo per lei. Mi mancava l'aria,
un peso impalpabile mi opprimeva il cuore e mi convinsi che, l'unico modo
per liberarmene, fosse quello di vedere sparire per sempre mia suocera
dalla mia vita. Così chiudevo gli occhi e sognavo la mia vendetta.
La prima volta che Ferenc venne a farci visita al castello non potrò
mai scordarla. Era una sera di un rigido inverno, i vetri erano appannati
come a voler nascondere la bufera che fuori imperversava. Una coltre di
neve imbiancava ogni cosa facendomi apparire il paesaggio quasi irreale
ed immobile. Come in un quadro. Il fuoco scoppiettava nel camino lanciando
incerti bagliori sul pavimento mentre ombre scure si arrampicavano sulle
pareti distorcendo la reale forma degli oggetti. Malgrado quell' intenso
calore che riempiva la grande stanza era come se nulla potesse scaldarmi.
A tal punto che, mille volte, avrei preferito montare in sella al mio
cavallo e fuggire lontano galoppando nella neve, sferzata dal vento gelido.
I quadri austeri, i mobili lussuosi così come ogni più piccolo
e insignificante oggetto della casa, non facevano altro che aumentare
la mia oppressione facendomi sentire a disagio. Era come se nulla mi appartenesse
malgrado la possedessi.
Quando lui entrò ricordo che rimasi immobile e lo guardai fissa,
senza lasciar trasparire la mia curiosità, senza donargli un sorriso.
Nel suo viso vidi che qualcosa cambiò ma non capii subito che cosa
fosse accaduto.
Non proferii parola, non feci nulla di fronte a lui oltre lanciargli quello
sguardo breve, dopodiché me ne andai voltandogli le spalle sfacciata,
lasciandolo solo. A passo svelto, forse un po’ intimorita dal fatto
che potesse decidere di seguirmi, andai a trovare rifugio nella stalla;
tra i miei adorati cavalli. Mi avvicinai a uno di essi che mi guardò
con quegli occhi grandi e languidi ed iniziai a carezzargli il muso caldo
e morbido ripensando ai lineamenti del mio futuro sposo. Improvvisamente
una sorta di bagliore mi attraversò la mente e tutto mi ritornò
chiaro. Ferenc aveva provato soggezione quando lo avevo guardato! Doveva
essere proprio così. Mi portai una mano davanti alle labbra per
soffocare una risata scoprendo per la prima volta quell' inspiegabile
attrazione che nasce d'improvviso tra due persone. Quel fatto forse poco
importante mi faceva sentire più forte, meno spaventata da quella
nuova vita che il futuro mi riservava.
Fu da quella volta che iniziai a divertirmi con lui.
Le rare volte che tornava a farci visita io ripetevo lo stesso gioco.
Lo fissavo il più intensamente che riuscivo, socchiudevo leggermente
le mie labbra rosse e carnose pur senza lasciar trasparire alcuna emozione
e quando credevo lui avesse intenzione di dirmi qualcosa, quando una leggera
eccitazione illuminava il suo sguardo, mi ritiravo di fretta nelle mie
stanze senza più voltarmi e potendo solo immaginare la sua espressione
sbigottita. E la mia prima impressione si rivelò reale. Ferenc
era turbato dall'intensità del mio sguardo spregiudicato, tuttavia
ne era anche terribilmente affascinato. Ne era infastidito e nel contempo
attratto e sopratutto mi desiderava. Estasiato dal mio aspetto e inspiegabilmente
sconvolto dai miei superbi silenzi. È sorprendente come gli occhi
ci rivelino più delle parole e del corpo: possono recitare o essere
sinceri, illuderci o darci certezze, essere nostri complici nei nostri
giochi o nei nostri inganni. Ed io, dei miei occhi, sapevo fare buon uso.
Di Ferenc avevo imparato che quando si sentiva inerme iniziava a stropicciarsi
il bordo della giacca. Imbarazzato a tal punto da non riuscire a stare
immobile: il grande Eroe Nero d'Ungheria spogliato di tutto il suo virile
coraggio da una bambina. Tuttavia sosteneva sempre il mio sguardo senza
perdere mai la sua fierezza: questo mi piaceva.
 |
| Ferenc Nádasdy, il «bey nero», marito di Erzsébet. |
Arrivò
il giorno delle nozze, un tiepido dì di maggio del 1575 nell'austero
castello di Varannò. Nozze che si protrassero per più di
un mese, con banchetti, danze e feste. Il mio abito nuziale era meraviglioso,
confezionato con perfezione impeccabile, impreziosito da perle e pietre
brillanti e sotto di esso comandai che fossero cuciti talismani che mi
assicurassero amore, fecondità, l'essere sempre desiderata e conservare
per sempre la mia bellezza.
Mi piaceva sentirmi il centro di ogni giornata, la bellissima regina della
festa. Era stupendo. Quando passavo, tenuta sottobraccio da Ferenc, la
gente si scostava gentilmente, sorridendoci e urlandoci auguri. Ovunque
v'era gente che rideva e chiacchierava animatamente e nell'aria aleggiavano
auguri per un futuro felice e complimenti per il mio abito e la mia acconciatura.
Ma per tutto il primo giorno di quello splendido mese, io attesi fremente
ben altro. E ogni volta che vi pensavo, il cuore sembrava voler smettere
di battere e il respiro mi si spegneva in preda all'emozione. Un giorno
che mi apparve interminabile, pervasa da così tante e intense sensazioni.
Paura, gioia, trepidazione e allegria si mischiavano diventando una cosa
sola.
Ma ecco che finalmente il sole scomparve alla vista lasciando posto ad
una notte serena e luminosa. Il momento era giunto. Intensa e illuminante
fu la mia iniziazione ai piaceri della carne. In una stanza lussuosamente
arredata, ove ovunque si dirigesse lo sguardo era ricchezza e sfarzo,
finalmente scoprivo quel nuovo contatto, finalmente mi veniva rivelato
il lato proibito del corpo maschile di cui tanto mi avevano raccontato
ma di cui avevo solo potuto fantasticare fino a quel momento. Dal primo
istante che fu in me, in un fondersi di piacere e dolore, capii che solo
lui non sarebbe bastato, capii che avrei voluto provare tutto ciò
che si può provare. Da quella volta, ogni notte gli chiedevo di
più, ogni notte esigevo di provare piaceri nuovi; spesso lasciandolo
disorientato dalle mie bizzarre richieste. Non potei diventare padrona
della mia stessa dimora ma era indiscutibilmente certo che lo divenni
del letto.
Purtroppo erano molto rare le volte che potevamo incontrarci, sempre tenuto
distante dalla guerra e da suoi doveri.
E la mia vita ricadeva nella monotonia e nella solitudine.
Il nuovo castello in cui ci eravamo trasferiti si trovava Csjethe. Il
paese era costituito da poche e piccole case, semplici e graziose, circondate
da campi di grano e da vigneti. Uno dei due castelli di Ferenc si trovava
proprio al centro di quel villaggio ma quella che invece divenne la mia
nuova dimora era arroccata su di uno sperone di granito, solitaria e difficilmente
raggiungibile. Il sentiero che vi conduceva era impervio e si snodava
tra rocce fino ad una foresta.
Dovetti trattenere il fiato quando lo potei osservare per la prima volta,
ancora distante, che si stagliava cupo contro gli ultimi bagliori del
tramonto. Una sagoma scura pronta ad inghiottirmi che mi colmò
di un tale senso d’oppressione che non so ancora spiegarmi cosa
mi trattenne dall’abbandonare la carrozza e fuggire via lontano.
Lì mi sentivo chiusa in una gabbia, confinata ai margini della
realtà. Orsolya vi si sistemò con me, insieme a due damigelle
che aveva scelto personalmente poiché mi accudissero instancabilmente
ed esaudissero ogni mia richiesta finendo però col controllare
ogni mio movimento in modo insopportabile. Ferenc era ripartito subito
per battagliare contro i Turchi e la vita era ritornata tediosa. Essendomi
stato proibito dalla suocera il culto della bellezza che tanto agognavo,
camminavo per le segrete e per i corridoi ancora animata dal sogno di
poter essere quella contessa spensierata che altro non doveva fare se
non occuparsi della sua persona. Leggere mi era impossibile: gli scritti
di battaglie e di imprese eroiche che tanto amavo erano banditi da quella
casa. Abbondavano invece libri di storia e a carattere religioso che riempivano
gli scaffali della libreria e che per nulla suscitavano il mio interesse.
Fu così che scoprii nello specchio la mia vera gioia: vi vedevo
un amico, un fratello ma sopratutto Erzsébet. L'immagine riflessa
non doveva infatti nascondere a nessuno quello che era e desiderava. Fu
lei ad insegnarmi che il mio primo vero dovere era quello di essere semplicemente
me.
Me ne stavo nella mia stanza, situata nel luogo più tranquillo
e silenzioso del castello, le pareti avvolte di damasco scuro, a terra
grandi tappeti orientali e sul tavolo una lampada che bruciava oli profumati
dal dolce odore orientale. Tenevo le imposte quasi sempre accostate in
modo da lasciar filtrare solo il chiarore necessario per potermi guardare
allo specchio poiché, la mia testa e i miei occhi, risentivano
terribilmente della troppa luce.
Adesso che ero maritata potevo permettermi di trascorrere ogni istante
ad osservarmi. Spesso non abbandonavo il mio riflesso per giorni interi
e se la notte mi svegliavo a seguito di uno spiacevole sogno e faticavo
a riprendere il sonno, mi sedevo lì e mi guardavo sorridendomi,
lasciando scivolare il mio sguardo su ogni parte del mio corpo.
Il compito primo delle mie serve era divenuto quello di pettinarmi e agghindarmi
come io comandavo. Punto sul quale ero molto esigente e severa. Arrivavo
a cambiarmi d'abito fino a quindici volte al giorno e per essi prediligevo
il bianco che sembrava fondersi con il candore latteo della mia pelle.
Mi truccavo le labbra morbide e scarlatte rendendole ancora più
sensuali ed invitanti, socchiuse come un bocciolo di rosa in attesa di
essere baciato dal suo primo raggio di sole e adoravo vedere i miei capelli
corvini adornati di cascate di perle come gocce di rugiada. Nella mente
continuavo a ripetermi che non c'era poesia più musicale della
mia bellezza.
Una cosa che però riusciva a spazientirmi terribilmente era quando
le serve mi volgevano dei complimenti. Stupide ed ignoranti serve! Cosa
speravano di ottenere elogiando la mia bellezza? Chi poteva avere la presunzione
di donarmi un elogio? Solo io potevo apprendere appieno quello che ero.
Solo io che sapevo osservare ogni parte di me potevo affermare la mia
bellezza. Un apprezzamento di una serva era uno sciocco tentativo di riscuotere
una qualche gratificazione. Così come se un uomo affermava di amare
le mie labbra con le parole, col pensiero già stava scivolando
tra le mie gambe.
Ma anche durante il culto del mio corpo non potevo mai stare tranquilla.
L'insopportabile Orsolya, che vedeva la donna solo come moglie e madre,
troppo spesso saliva nelle mie stanze sospettosa della mia disobbedienza.
Allora ecco che, ogni qualvolta sentivo i suoi passi avvicinarsi, dovevo
spogliarmi frettolosa di tutti i miei gioielli per non essere scoperta
e rimproverata. Quando ero in preda alle convulsioni, stesa nel mio letto
e distrutta dal mio malessere lei si sporgeva alla porta della mia camera
e mi osservava brevemente per poi chiedere alla domestica notizie sulla
mia salute. Mentre una morsa invisibile sembrava voler spezzare il mio
cranio, nulla mi appariva più disgustoso della sua presenza che
sapevo bene nutrisse solo due speranze: che morissi o che fossi rimasta
gravida.
In una famiglia nobile come la mia e com’era quella di Ferenc era
impensabile che non ci fossero eredi. Ed io non sapevo se ringraziare
quel dio che Orsolya pregava con tanto ardore o quell’essere diabolico
e così affascinante che mia zia segretamente adorava, per impedire
che i suoi desideri di avere un nipote trovassero realizzo. Ma infine
preferivo lodare me stessa convinta che ogni singolo avvenimento dipendesse
solo dalla mia forza di volontà. E i miei desideri si avverarono.
—
Terribilmente
noiose erano, per me, anche le feste che ero costretta ad organizzare
con mesi e mesi di anticipo di modo che tutto fosse perfetto, anche se
l'arrivo di Ferenc mi colmava di gioia come risvegliandomi da un incubo
senza fine.
Malgrado i preparativi non abbandonavo la cura di me, risultandomi atroce
il distacco troppo prolungato dallo specchio. Ordinai che venisse costruito,
nell'anticamera della mia stanza, un laboratorio per distillare le erbe
e i fiori, bruciare le piante, ove le mie serve iniziarono a lavorare
assiduamente per la creazione di cosmetici che mantenessero la mia pelle
sempre fresca e delicata; consapevoli della mia incontrollabile ira nel
caso il loro lavoro non mi avesse pienamente soddisfatta.
Così, ai banchetti, mi presentavo sempre impeccabile, curata in
ogni particolare ed osservata da ogni uomo che, come era successo con
Ferenc, mi bramava pur temendomi. Orsolya, come sempre, osservava i miei
movimenti con aria rassegnata disapprovando il mio modo di vestire e la
mia ossessione per la perfezione pur non potendo esprimere il suo disappunto
davanti al figlio. Innegabile era la gratificazione che provavo a sentirmi
tanto desiderata e temuta, a vedere come era difficile per gli altri controllare
l'istinto erotico che scaturiva in loro alla mia vista. Ma più
forte era il disprezzo che gli invitati mi suscitavano; tale al punto
che, durante i nostri discorsi, il mio tono si faceva sprezzante e spesso
li colpivo sfrontatamente con battute sarcastiche e pungenti.
Il mio vero desiderio sarebbe stato di poter organizzare feste per i miei
parenti, uniche persone con cui mi sentivo in sintonia. Ma questo non
avvenne mai.
I membri della mia famiglia erano da tutti temuti per la loro fama che
li descriveva crudeli e stravaganti, ma c'era di più: una sera
casualmente mi trovai di passare davanti alla porta del salotto che era
stata lasciata sbadatamente socchiusa da una domestica. Compresi il nome
di mia zia Klarà e questo mi fece subito fermare ad ascoltare.
Ad Orsolya brillavano gli occhi mentre sputava aspramente sentenze, mentre
definiva mia zia una lesbica disgustosa, mio fratello un crudele pervertito,
la mia famiglia votata al culto del demonio.
Senza nemmeno un attimo di indecisione spalancai la porta e guardai con
aria severa Orsolya, suo marito e Ferenc. Fra loro calò un silenzio
forzato e spiacevole ed io socchiusi le labbra pronta ad inveirgli contro,
sentendo bruciare sulla mia lingua i peggiori insulti che si potevano
immaginare. Poi ci ripensai e non dissi nulla, ben sapendo che a poco
sarebbero servite le mie parole. Me ne andai lasciandoli sbigottiti a
domandarsi quanto io avevo potuto udire del discorso e a scambiarsi sguardi
colpevoli e mortificati.
Risalii le scale e una volta sola nella mia stanza, saltai sul letto e
scoppiai a ridere fino a farmi brillare gli occhi di lacrime: oh come
avevano ragione ad affermare quelle cose sulla mia famiglia e quanto ero
fiera di avere parenti così inusuali. Era proprio quello che ci
teneva e che ci avrebbe tenuti sempre, un gradino sopra la noiosa normalità.
Certo è che, dopo quell' avvenimento, nessuno osò più
nominare alcun membro della mia famiglia.
Come fu dolce quella notte Ferenc mentre goffamente tentava di trasformare
il sesso nelle carezze dell'amore: mi sfiorava con delicatezza come mai
aveva fatto, nel tentativo di cancellare in me il ricordo di quello che
era successo poco prima. Ogni tanto mi guardava furtivo cercando di cogliere,
probabilmente, una resa alla mia posizione. Ma io mai gli concessi un
cedimento né gli diedi la soddisfazione di ripartire con il cuore
più leggero mentre dentro di me godevo. Ma non del piacere che
voleva donarmi bensì di quello che nasceva dalla mia piccola vittoria.
Oh
Ferenc, che singolare personaggio. Non posso non ammettere che la sua
rara compagnia fosse piacevole. Certamente mai lo disprezzai. Ricordo
che una volta mi lamentai dell’inadempienza di una serva e gli dissi
che doveva essere assolutamente punita. La sua reazione mi lasciò
realmente stupita: non solo assecondò la mia decisione ma quale
stravagante idea ebbe! La ragazza fu presa e costretta immobile da dei
legacci. Dopodiché, tra le dita dei piedi e delle mani le furono
sistemati dei pezzi di carta a cui venne dato fuoco... Nella testa adesso
ho ancora le urla della giovane che si contorceva e cercava di sottrarsi
a quel dolore senza avere via di scampo.
Mio marito stava eretto, immobile, osservando la scena senza proferire
parola, impassibile, lo sguardo duro e severo. Io lo spiai brevemente
e mai mi era apparso così bello come in quel momento, fiero e spietato.
Ritornai quindi a guardare la scena senza più distogliere la mia
attenzione mentre, le mie dita sottili, cercarono quelle di lui e si strinsero
intorno alla sua mano. Egli ricambiò come se volesse infondermi
un po' di coraggio senza sapere che, se anche solo per un attimo si fosse
voltato a guardarmi, avrebbe scoperto che stavo sorridendo.
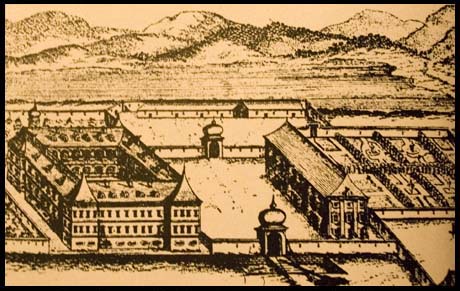 |
Németkeresztúr,
il castello di Erzsébet Báthory. |
Presto
le mie notti solitarie iniziarono ad essere torturate da incubi e troppo
spesso mi svegliavo di soprassalto: il terrore di invecchiare mi tormentava
ogni giorno e adesso mi privava anche del sonno. Allora correvo davanti
allo specchio e mi rimiravo con il cuore in gola scacciando l'immagine
della mia pelle che si ingialliva e dei miei capelli che si ingrigivano.
Sapevo che non avrei potuto sopportare la vecchiaia, mai avrei potuto
accettare di perdere il mio fascino, di stare ad osservare impotente il
mo decadimento fisico. Come per ogni cosa che si sa essere priva di soluzione,
il mio cuore si colmava d'angoscia ed il futuro mi appariva pari ad una
caduta imminente verso un pozzo senza fondo. Non esisteva appiglio né
possibilità di risalita. Al tempo non si può tornare indietro
e se v’era una speranza dovevo lottare e studiare per trovarla,
prima che fosse troppo tardi.
La scoperta del mondo esoterico fu per me un piacevole diversivo in grado
di rendermi un po’ più tranquilla. Molte infatti erano le
pozioni e gli unguenti volti a contrastare l'incedere inesorabile degli
anni anche se, tristemente, si rivelarono inefficaci. Spesso scrivevo
a mio marito aggiornandolo su ciò che apprendevo e sui progressi
che facevo nel campo di queste arti malgrado lui non sembrasse per nulla
in grado di condividere i miei interessi.
Molto devo anche alla mia cara zia Klarà. Le serate trascorse con
lei mi facevano dimenticare il tedio che, come entravo nel mio castello,
mi seguiva come un’ombra impalpabile ma sempre presente. Con lei
ritrovavo il sorriso, con lei la vera Erzsebeth riemergeva in tutta la
sua complessa semplicità. Nemmeno la prima volta che partecipai
ad una serata da lei organizzata provai vergogna perché, per me,
l'unica cosa immorale era l’idea collettiva della moralità.
Stavo in piedi ad osservare l'enorme salone adornato di tappeti, stoffe
pregiate, arazzi e illuminato da luci soffuse. Chi sdraiato a terra, chi
sui sofà, chi in piedi contro i muri. Ovunque vi erano corpi nudi
che si stringevano, che si contorcevano dal piacere. Non c'era spettacolo
più appagante di quello. Un uomo nudo perdeva ogni potere agli
occhi della società, diveniva animale, cacciatore o preda, schiavo
solo della sua istintività. Ed era proprio dalla persona privata
dei suoi abiti civili che d’altronde scaturiva la forza più
pura, quella con il quale la natura ci rendeva partecipi di essa medesima.
Già bramosa di desiderio, elettrizzata dalla scoperta di nuove
esperienze, mi lasciai spogliare da una delle serve, senza perdere tempo.
Mia zia mi osservava compiaciuta, seduta poco distante.
Io chiusi gli occhi e mi abbandonai alle sole sensazioni, concentrandomi
appieno su di esse. Sapevo che, se davvero lo desideravo, il solo contatto
della stoffa delle mie gonne che scivolavano lungo i miei fianchi poteva
farmi fremere. Sentivo le mani delicate della ragazza che mi carezzavano
le spalle, i seni. Le sue labbra erano carnose e morbide tra le mie. Lasciai
che scivolasse lungo il mo corpo, lasciai che mi sfiorasse ovunque desiderasse.
La sua bocca si fermò al mio ombelico e sospirai per quel piacere
sottile. Inaspettatamente qualcuno mi afferrò le braccia e premette
il suo corpo nudo contro la mia schiena. Malgrado il mio stupore non aprii
gli occhi e rimasi immobile, sottomessa per gioco al potere di quello
sconosciuto. Fui costretta a piegarmi in avanti e mentre l'uomo mi faceva
sua e le sue mani callose trovavano appiglio ai miei seni, le labbra premevano
sul mio collo, graffiando la mia carne sottile con la barba incolta. Più
il suo piacere si faceva intenso e più la sua stretta diveniva
dolorosa.
La serva continuava a baciarmi; dolore piacere e dolcezza nello stesso
istante. Con una mano le presi il viso e cercai la sua bocca, calda, matura,
lasciandomi sfuggire un gemito. Spinta da un desiderio crescente serrai
la sua carne tra i miei denti candidi, sempre più forte, contrastando
il suo tentativo di divincolarsi per sfuggire a quel dolore inaspettato.
Quando sentii il suo sangue caldo sul mio palato allentai la presa ma
non la lasciai andare afferrandola anzi per la folta chioma castana.
Abbandonai l'uomo al suo piacere inconcluso e mi lanciai sulla ragazza
costringendola a sdraiarsi a terra. Lo sconosciuto invece, come impazzito
per non essere riuscito a placare i suoi sensi, si accanì come
un animale su di lei, immobilizzandola per i polsi usandola per raggiungere
l'oblio. Così io, potei approfittare della prigionia della serva,
sfruttandola, per operare su di lei, senza riuscire a trattenermi. Estasiata
le piantai le unghie lungo il petto, seguendone la curva gentile, fino
a farlo sanguinare. E più cercava di sfuggirmi, più urlava
e si dibatteva, più io provavo piacere. Nemmeno quel brutale spettacolo
riusciva a placare l’eccitazione dell'uomo, adesso così simile
ad una bestia, che anziché aiutarla a sfuggire alla mia furia la
costringeva sempre più all'immobilità.
Baciavo il suo corpo raccogliendo i rivoli del suo sangue ancora caldo,
dandole qualche attimo di sollievo per poi ritornare a infliggerle stuzzicanti
torture.
Dopo quella prima sera divenni un assidua frequentatrice delle orge di
Klarà ed ogni volta inventavo qualche nuova tortura da sperimentare
su qualche serva... Il piacere sessuale si mischiava al piacere di poter
infliggere dolore. Il rapporto tra vittima e carnefice mi esaltava più
di ogni altra cosa e completava la mia estasi. Spesso il mio raggiungimento
del piacere era così totale, così assoluto, che quasi mi
sentivo svenire e mi dovevo stendere a terra priva di forze.
Gli uomini godevano ad essere da me torturati, il mio potere su di loro
li estasiava, spesso mi supplicavano di essere crudele e quando, stanca,
smettevo di frustarli loro ne soffrivano tremendamente implorandomi di
continuare.
Guidata
esclusivamente dai sensi la mia vita era destinata a cambiare. Ancora.
Mi chiesi perché dovevo aspettare trepidante le serate nel castello
della zia quando potevo trovare diversivi anche nella mia dimora. Scoprii
con somma sorpresa che torturare le mie cameriere indifese mi procurava
una gioia inaspettata in grado di placare ogni mio dolore, ogni mia sofferenza,
ogni mia crisi e ogni mia infelicità.
Il mio preferito divertimento era quello di amare quelle donne, di dare
loro godimento fisico per poi subito annullarlo causando loro dolore.
Amavo penetrare il loro corpo di spille, osservare la loro sofferenza
e annusare la loro paura, profanare brutalmente il loro sesso per sentirle
gridare. Come un felino giocavo con la mia preda, la stuzzicavo lasciandole
la speranza della salvezza per poi riprendermela con prepotenza inaudita,
distruggendo definitivamente ogni sua illusione.
Erano così innocenti, così impotenti di fronte a me. Solo
delle serve senza diritto di replica, solo degli oggetti per saziare il
mio divertimento. Oggetti che però erano in grado di soffrire,
potevano piangere e urlare… Oh eccome se potevano urlare.
Decisi però che il modo migliore per continuare quel mio passatempo
senza destare troppa agitazione nella servitù fosse quello di motivare
le mie azioni. Non certo per giustificarmi con me stessa ma solo per non
turbare la mia servitù e rischiare qualche piccola rivolta. Quindi
commissionai le mie fedelissime di riferirmi ogni mancanza da parte loro.
Finalmente potevo sbizzarrirmi nelle più singolari e fantasiose
punizioni da infliggere. Punizioni alle quali pensavo durante tutto il
giorno bramosa di poterle finalmente mettere in atto.
Se una domestica aveva chiacchierato mentre rammendava i miei abiti era
con sommo piacere che io stessa le cucivo la bocca con del filo nero,
tenendole il viso stretto nella mano. Sorpresane una che aveva stirato
male ordinai che le fosse passato il ferro rovente sulla pianta dei piedi
e sulla faccia. Punizione ben più esemplare fu quella che infersi
ad una giovane serva che era stata scoperta a rubare degli spiccioli:
comandai che fosse legata ad un albero, nella foresta, e cosparsa di miele,
lasciata preda delle bestie feroci.
Raggiunsi l’apoteosi della crudeltà, bellezza ineguagliabile
e pura e al contempo atroce istintività. Raggiunsi quello ciò
che nessuno avrebbe potuto raggiungere; quella libertà che è
temibile abisso e magnifica perversione. L'essere umano, animale crudele
consapevole dell’immenso potere che la crudeltà dona. Come
un animale qual è, beve, si nutre e si accoppia per sopravvivere
ma una sottile peculiarità sembra caratterizzarlo: il trovare appagamento
nell'altrui frustrazione.
Il piacere che scaturisce dalle cosiddette forme di tortura accettate,
come in guerra, è in realtà il medesimo. Cambia la causa
d’origine ma l'eccitazione che ne scaturisce è dello stesso
segno. Rido dell’ipocrisia e della codardia della folla che si spinge
e si accalca intorno al rogo di una presunta strega lanciando insulti,
godendo più che nell’amplesso, per poi tornare a casa a pregare
Dio per i propri peccati.
Fui veramente libera quando Orsolya morì. Come mi ero promessa,
dopo tanto subire in silenzio e sopportare i suoi ordini finalmente ogni
sforzo veniva ripagato. Anni e anni di sopportazione valsero quel momento.
Mi avvicinai a lei e le sorrisi. Quindi mi sedetti sulla poltrona vicina
al suo capezzale. La donna stava lì e tutta la sua severità
che si era tenuta stretta fino all'ultimo adesso non aveva più
alcun senso e anzi appariva ridicola. Stavo con lei per ore, perfettamente
agghindata e profumata, carica di gioielli luccicanti proprio come lei
aveva sempre detestato vedermi e la osservavo con lo stesso sguardo remissivo
di sempre, godendo del suo odio verso di me, della sua insoddisfazione
verso la vita, della sua tristezza per non aver potuto godere dell'ultimo
dei pochi piaceri che le erano concessi: un nipote.
Sapendo di come la mia presenza in quel momento le risultasse insopportabile,
poco prima che spirasse, le strisciai delicatamente vicino. Così
vicino che potesse sentire il mio respiro caldo e giovane. Sapevo bene
che lei sapeva. Non ci sarebbe stato bisogno di sprecare parole. Lei era
perfettamente consapevole del fatto che mai ero stata in suo potere malgrado
avesse voluto illudersi. E adesso se ne sarebbe andata per sempre con
il tormento di come ogni suo sacrificio fosse stato vano, di come tutta
la sua vita fatta di privazioni fosse stata inutile. Se ne andava leggendo
la mia vittoria negli occhi, troppo debole per potermi esprimere, per
un ultima volta, il suo odio. Troppo debole per potermi allontanare da
lei. Sarebbe morta e l'ultimo sguardo che avrebbe dato al mondo sarebbe
stato volto al mio viso.
Le baciai la sua fronte ancora calda sentendomi pervadere da una inusuale
vitalità. Adesso ero libera, il castello era solo mio. Mi abbandonai
tra le braccia di Ferenc desiderando di amarlo e di essere amata, bramosa
di vedere il piacere sul suo volto mentre lo possedevo imprigionandolo
tra le mie gambe, sotto di me.
Ma accadde di più. Non posso affermare con certezza che avvenne
proprio quella notte o una delle successive, ma presto concepii il primo
dei miei quattro figli.
Amavo i miei figli sopra ogni cosa. Impossibile è per me spiegare
quale legame sentissi scorrere tra me e loro. Malgrado questo mai fui
spinta da un vero istinto materno, la loro gioia non mi rallegrava e i
loro pianti altro non facevano che innervosirmi. Per questo ero solita
lasciarli alle cure della balia Ilona Jò.
Senza Orsolya, fui finalmente libera di partire, potevo seguire mio marito
quando lo desideravo e frequenti furono le mie visite a Vienna dove ero
spesso ospitata dall'imperatore Rodolfo che sembrava decisamente debole
e disarmato dalla mia personalità, dai miei modi e dal mio fascino.
Nonostante i miei viaggi mai pensai di abbandonare le mie pratiche, nemmeno
per un istante. Sopratutto dopo la morte di Ferenc ebbi modo di dedicarmi
appieno alle arti oscure cui già da tempo ero stata iniziata, bramosa
di appenderle in ogni sfaccettatura.
Con gli anni mi ero accerchiata di poche persone che si erano guadagnate
la mia fiducia e che sapevo a me ciecamente devoti. Tra queste c'era la
fattucchiera e fedelissima Dorottya Sentezs detta Dorkò, la balia
Ilona e il valletto nano Jànos Ùjvàry detto Ficzkò.
Quest' ultimo era stato abbandonato dai genitori per la propria bruttezza
e deformità per poi essere salvato da Ferenc che l'aveva fatto
allevare da un pastore per poi accoglierlo a corte come buffone. Era da
subito risultato un personaggio divertente, apprezzato per il suo sarcasmo
brutale e la sia pungente ironia.
Per Ficzkò il mio arrivo al castello fu una liberazione. Scoprimmo
entrambe di avere qualcosa in comune: quel piacere nella tortura. Di chi
mi sarei potuta fidare di più se non di una persona che provava
la mia medesima eccitazione nello sperimentare l'altrui dolore?
Fu grazie a loro e a molti interessanti personaggi che ebbi modo conoscere
nel corso degli anni che potei perfezionare le mie arti magiche realizzando
incantesimi e malefici.
Non fu quindi per animo caritatevole che il mio castello divenne - soprattutto
in seguito alla morte di Ferenc - un rifugio per maghi e fattucchiere
che cercavano di sfuggire all'opera di repressione della Chiesa bensì
per apprendere da loro ogni arte e ogni segreto. Avevo sete di sapere
tanto quanto avevo sete di sangue.
Continua in Ctonia -3...
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI
Thorne, Tony, La contessa Dracula – La vita e i delitti di Erzsébet
Báthory, Milano, Mondadori, 1998.
Tani, Cinzia, Assassine, Milano, Mondadori, 1998.
Manuela
Simoni - porcelain-cat@hotmail.it